Oscar le aveva dato un appuntamento a Santa Maria in Trastevere. Erano anni che nessuno le dava un appuntamento così. Devo venire vestita di bianco, gli aveva detto al telefono, o vanno bene anche i pantaloni? Oscar si era messo a ridere. D’accordo, vediamoci davanti alla fontana, è meno impegnativo, Ci vuole poco, a farti cambiare idea, Mi basta sapere che arriverai, Non ti preoccupare, ci sarò.
A piazza Santa Maria in Trastevere, naturalmente, – mi dice Fabio Stassi, quando gli chiedo di rivederci, a distanza di un anno, per chiacchierare del suo nuovo romanzo – dove Oscar dà un appuntamento improbabile a Soledad nei luoghi della sua giovinezza. Ti aspetto lì.
Sembra davvero che il tempo non sia passato e di riprendere una conversazione mai interrotta. (Il precedente Chiacchierando con Fabio Stassi)
Ho terminato di leggere Come un respiro interrotto (Sellerio, 2014). Mai titolo più affascinante. Forse il più bello tra i tuoi. Ho trattenuto il respiro, sospesa come in apnea. Una lettura per me particolarmente emozionante, perché ho ritrovato tra le pagine alcune suggestioni della nostra chiacchierata di un anno fa, momento in cui credo tu stessi già a buon punto con il romanzo.
Come un respiro interrotto è un ritorno?
La mia impressione è che qui ci sia tutto lo Stassi dei libri precedenti, ma con una carica personale molto più forte e suggestiva. Se già la tua scrittura aveva uno stile consapevole e maturo, con questo nuovo romanzo dai fiato pienamente alla tua voce più vera e profonda. C’è quello che sei stato, la passione per personaggi straordinari ritagliati in uno spazio molto intimo, l’amore per la musica, il tema della morte, il tono vicino alla migliore letteratura latinoamericana, l’atmosfera sospesa con cui avvolgi i tuoi personaggi, ma mi sembra di scorgere anche quello che sei diventato. Un cantore sommesso e delicato delle pieghe più recondite dell’animo umano. La tua scrittura si fa davvero respiro, in questo romanzo.
Nello stesso tempo trovo che questo sia il tuo romanzo più personale. Quello in cui mi sembra che avvicini lo sguardo di scrittore al tuo cuore, alla tua generazione, a quello che è stato un periodo contradditorio per l’Italia e per chi credeva di poter migliorare la società.
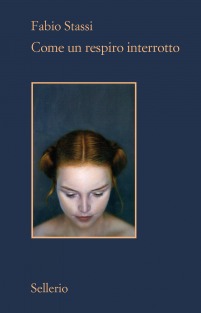
Sì, Giuditta, questo libro è proprio questo: un ritorno, o almeno il tentativo di un impossibile ritorno a casa. Sono felice di riprendere la nostra chiacchierata proprio dal punto in cui l’avevamo interrotta, dagli stessi temi, quasi dalle stesse parole, e ti ringrazio per tutte le cose belle e generose che scrivi. Con molto pudore, devo dirti che anche per me Come un respiro è il romanzo più personale che ho scritto, il più emotivo, quello che mi contiene interamente. Ma la cosa curiosa che accade è che sto ricevendo tante lettere particolari, di lettori che ci si riconoscono o si sono riconosciuti in certi passaggi del libro, in certe esperienze, e questo continua a sorprendermi: è come dire che più una storia ti appartiene, più appartiene anche agli altri. E questo mi dà una grande gioia, perché è quello che avevo cercato di fare: scrivere allo stesso tempo un libro che fosse il più privato e insieme il più corale tra quelli che avevo scritto sinora. Naturalmente, so che è solo per la benevolenza e l’affetto di alcuni lettori, e per la loro empatia, se provo l’illusione di essermi, in qualche pagina, avvicinato alle mie intenzioni più ambiziose, ma mi sembra di ricavarne una piccola lezione, che le cose più intime, alla fine, siano le più universali.
Un ritorno, dicevi. Sì, dopo tanti giri del mondo, in treno e nei libri, sentivo davvero la necessità di tornare nelle strade della città dove ero cresciuto, nella famiglia che mi aveva allevato, all’isola da cui provenivo. In definitiva, al tempo e alla geografia del mio sangue. Avevo necessità di chiamare tutto finalmente con il suo nome, senza alterare più i calendari e mettere sottosopra le mappe. Con Soledad, con la sua storia, avevo un appuntamento da sempre, eppure avevo continuato a rimandarlo per anni, non mi sentivo pronto, avevo paura di azzerare la distanza con lei e con quello che lei rappresentava. Poi l’ho vista, nella casa vuota della sua infanzia, dopo la morte di sua madre e lo sfratto di suo padre. Era lì, al centro di questo appartamento deserto. L’ho vista trattenersi per ultima e attaccare dei post-it al muro nei luoghi dove c’erano stati per cinquant’anni un telefono, dei mobili, un letto… come se la scrittura o la musica o il canto potessero far tornare gli oggetti, e le persone, e le idee, al loro posto, riarredare in qualche modo la mancanza.
Tu sei il cantore dell’intimità. Ma è vero che in questo ultimo romanzo si avverte una percezione emotiva molto forte che travolge e avvolge il lettore. Anche io, un po’ più giovane dei tuoi protagonisti, mi sono sentita coinvolta e partecipe, nonostante poi i fatti che intessono le loro storie e che in un certo senso li guidano e li indirizzano siano lontani dalla mia esperienza, non tanto da essere Storia, ma quel tanto per non essere più presente.
C’è nel romanzo l’urgenza di fare i conti con un’epoca, un momento decisivo e complesso della storia degli italiani? Una storia che ha segnato un’intera generazione, e con cui è ancora difficile fare i conti, decidere i torti e le ragioni? Perché io come lettrice l’ho avvertita nelle tue pagine, ma declinata in modo nuovo, indiretto, non posso che dire intimo e personale.
La coralità. Anche nei romanzi precedenti accanto al protagonista del romanzo, vero anche se romanzato, Charlie Chaplin e Capablanca, per citare i miei preferiti, si muovevano una molteplicità di figure secondarie, fascinose ricche e complesse. Però in questo ultimo, nonostante la pienezza e il fascino di Sole (che non è un personaggio reale?) le altre figure a partire da Matteo, Nino, e la straordinaria famiglia della ragazza, primo fra tutti lo Zapatero mi sembra che assurgano a una maggiore importanza, corollario necessario e imprescindibile. Insomma stenterei a dare a Sole il ruolo che Chaplin ha in L’ultimo ballo di Charlot (di cui ho parlato QUI) e Capablanca in La rivincita di Capablanca (di cui ho parlato QUI) (già a partire dal titolo?)
Infine (con te è sempre difficile tenere a freno le mille suggestioni che si aprono nelle tue risposte) il ritorno in Come un respiro interrotto è anche linguistico? Mi sembra (correggimi se sbaglio!) che sia la prima volta che nei tuoi romanzi appare il dialetto, in alcune inserzioni di siciliano, o la lingua del cuore di nonna Lupe.
 In questi ultimi viaggi in treno, per andare nella biblioteca dove lavoro o agli incontri con le scuole o con i lettori, mi ha fatto molta compagnia il carteggio tra Coetzee e Paul Auster, “Qui e ora”, pubblicato da Einaudi un paio di anni fa. Loro due sono tra gli scrittori contemporanei che ammiro di più. Alla fine di una lettera, Coetzee si interroga su cosa è accaduto “tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta”. Paul Auster prova ad imbastire delle risposte: il trionfo definitivo del capitalismo, la vittoria della cultura pop sulla cultura “alta”, il crollo del comunismo e dell’idealismo rivoluzionario, ma confessa che più ci meditava sopra, più aveva la sensazione di scrivere “un necrologio dei miei tempi, della mia vita.” “Forse sviscerando questi temi si possono trovare delle risposte, ma io non ho trovato altro che tristezza” dice.
In questi ultimi viaggi in treno, per andare nella biblioteca dove lavoro o agli incontri con le scuole o con i lettori, mi ha fatto molta compagnia il carteggio tra Coetzee e Paul Auster, “Qui e ora”, pubblicato da Einaudi un paio di anni fa. Loro due sono tra gli scrittori contemporanei che ammiro di più. Alla fine di una lettera, Coetzee si interroga su cosa è accaduto “tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta”. Paul Auster prova ad imbastire delle risposte: il trionfo definitivo del capitalismo, la vittoria della cultura pop sulla cultura “alta”, il crollo del comunismo e dell’idealismo rivoluzionario, ma confessa che più ci meditava sopra, più aveva la sensazione di scrivere “un necrologio dei miei tempi, della mia vita.” “Forse sviscerando questi temi si possono trovare delle risposte, ma io non ho trovato altro che tristezza” dice.
Ecco, so che rischiare un bilancio, un rendiconto sia privato che addirittura generazionale su quegli anni che fanno da sfondo alle avventure musicali dei miei personaggi, è stata un’intenzione smisurata e incosciente. Un azzardo, un salto nel vuoto. Me ne rendo conto meglio adesso: un po’ è davvero così, è stato come scrivere il proprio necrologio e il necrologio di quello che ho vissuto. Forse per questo avevo cercato di differire questo libro in ogni modo. Di prendere tempo. Scrivevo del Brasile, e di Cuba, e della California, ma sapevo che prima o poi sarei dovuto tornare a casa, che con questa storia, che era la più mia di tutte, e con la Storia e la Città nella quale sono cresciuto, avevo un appuntamento.
Ho portato con me un quaderno per anni. L’ho riempito di appunti. Intanto la vita andava avanti, con i suoi accadimenti tristi o gioiosi, e contaminava tutto. Mi chiedevo come avrei potuto attraversare quel senso di tristezza così lancinante di cui parla Paul Auster. A lungo non ci sono riuscito. Intanto il quaderno mi si riempiva di pagine e di personaggi, e tutti avevano la stessa necessità, la stessa parità, secondo uno strano criterio di uguaglianza. E per davvero più quello che volevo raccontare era personale, più diventava di tutti. Ma mi sarebbe servito disporre di molta più tecnica di quella che ho. Così mi sono messo a ristudiare gli scrittori che amo di più. Ho riletto Saramago. Ho riletto Garcia Marquez, che mi manca visceralmente. Un suo libro fu decisivo nella mia giovinezza, non Cent’anni di solitudine. Quello dopo, forse il meno fortunato dei suoi: L’autunno del patriarca. Io credo sia il suo capolavoro, un manuale ricchissimo di letteratura nel quale è mostrato magistralmente tutto quello che si può fare con un romanzo.
Ma prima di mettere insieme quanto avevo scritto, e di portarlo a termine, è dovuto passare ancora del tempo. È dovuto arrivare il momento in cui si perde la casa dell’infanzia, e si smette di provare nostalgia, quando si sente che davvero è finalmente troppo tardi per tutto e che molte cose sono definitivamente finite, e per questo forse si possono raccontare.Ma è difficile parlare, e scrivere, di nostalgia. Del desiderio di un ritorno. A un certo punto, verso la fine del libro, Sole dice che ogni volta che passava da Roma saliva al Gianicolo per recitare la plegaria de la vuelta, la preghiera del ritorno.
La nostalgia è un sentimento pieno di insidie retoriche, di imboscate, di sabbie mobili. Senz’altro uno dei più umani, ma il più complesso da rappresentare, per me. Per cercare di scriverne nel modo più onesto possibile, ho aspettato molto. Ma non per interporre una distanza. Anzi. Non so spiegarlo bene. Ho aspettato di non avere più nostalgia per riattraversarla per intero, e da capo, ma senza trucchi. Senza nessuna soluzione da dichiarare, senza nessuna intelligenza da esibire. Accettando solo la scommessa di provare a restituire il respiro di un’utopia smarrita, di quella speranza di rovesciare il mondo che non riusciamo neppure più a ricordare. O più semplicemente di ritornare nella casa dove si è imparato a nominare per la prima volta le cose. Parafrasando il titolo della canzone di Jimi Hendrix che canta anche Sole, io non lo so perché il sei non è stato nove, ma non voglio dimenticare di averlo desiderato.
E la nostalgia è tornata nella lingua, attraverso la lingua. La nostalgia batte nel cuore delle parole. Nel dialetto dell’infanzia, nella lingua mista di Nonna Lupe, storta come i suoi piedi. Nel lessico famigliare di una generazione. Nell’alfabetiere sconvolto della mia e della nostra memoria.
Mi ero dato questa regola: questa storia avrebbe avuto ventisei parti. Quante i caratteri di un alfabeto occidentale allargato. Al ventiseiesimo capitolo mi sarei fermato. Ma per scombinare tutto, a ritroso. Per mettere in fila i segni di un alfabetiere impazzito. Alterare la linea cronologica dei fatti. Mischiare tutte le lettere, e le voci, e il tempo, come fanno i bambini, per riuscire a far diventare per davvero corale ciò che è intimo, e ricomposto e unito ciò che è frammentario.
Forse il tema di fondo di qualsiasi analisi, letteraria o storiografica o politica, su quanto è accaduto tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, che ci provoca ancora tanto dolore, è la sconfitta. Forse scrivere di una sconfitta è sempre una scrittura testamentaria. Ma, insegna Iosif Brodskij, un uomo libero quando è sconfitto non dà la colpa a nessuno.
Carissimo Fabio, l’attesa di questa mail (non la fretta di riceverla!) – Eh, sì, di nuovo, come sempre la chiacchierata è stata mediata dallo scambio di mail, ma con Fabio Stassi più che con ogni altro verrà il giorno in cui chiacchiereremo guardandoci negli occhi e quella sarà la volta più bella!- ha reso ancora più difficile staccarsi dal tuo libro! Tra tutte la figura a cui ripenso con più persistente dolcezza è quella dello Zapatero. Il personaggio più silenzioso, il più enigmatico, quello che meno ha agito, resta indelebile nel cuore, come una figura mitica e leggendaria, un traghettatore tra la vita e la morte, del tutto diverso da quelli classici accigliati e mostruosi. In effetti il tema della morte nelle tue pagine ha sempre una sua misteriosa dolcezza. La morte non è mai violenta, misera forse, certo dolorosa, determinata nelle sue scelte, mai tragica o crudele.
 Bufalino, in una sua raccolta di saggi, La luce e il lutto, parla dell’insularità dei siciliani, dell’incredibile potere di fascinazione che ha, per un siciliano, una stanza vuota, della pulsione di seppellirsi in una casa. Ma anche del sentimento opposto, della voglia di uscire dall’isola, di fuggire. Bufalino la chiama un’oscillazione permanente tra claustrofilia e claustrofobia, tra odio e amor di clausura. Ho cercato di rappresentare questa dialettica che di solito avviene all’interno dello stesso uomo con due personaggi: zio Pepe, quello che ha trascinato la famiglia fuori, che li ha portati a Roma, e lo Zapatero, che invece vive la sua vita dentro una cucina, a risuolare scarpe per i morti.
Bufalino, in una sua raccolta di saggi, La luce e il lutto, parla dell’insularità dei siciliani, dell’incredibile potere di fascinazione che ha, per un siciliano, una stanza vuota, della pulsione di seppellirsi in una casa. Ma anche del sentimento opposto, della voglia di uscire dall’isola, di fuggire. Bufalino la chiama un’oscillazione permanente tra claustrofilia e claustrofobia, tra odio e amor di clausura. Ho cercato di rappresentare questa dialettica che di solito avviene all’interno dello stesso uomo con due personaggi: zio Pepe, quello che ha trascinato la famiglia fuori, che li ha portati a Roma, e lo Zapatero, che invece vive la sua vita dentro una cucina, a risuolare scarpe per i morti.
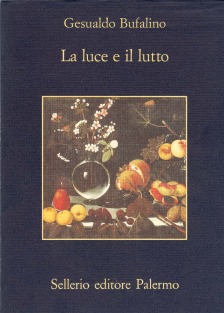
Ma hai ragione: è lo Zapatero il personaggio al quale sono più legato. Me lo porto dietro da sempre. Somiglia a uno zio che ho conosciuto da bambino. Aveva già fatto delle apparizioni nei libri precedenti, ma quasi in punta di piedi. In certi passaggi, in certe frasi. Il suo è un mistero che non smette di interrogarmi. Ho addirittura riempito un quaderno di versioni diverse della sua cucina. È come se per me scrivere fosse cercare di scoprire quale storia, quale segreto nasconde, un uomo che si rifiuta di vivere e si barrica in una tana. È un po’ la coscienza della casa degli alberi diapason. L’orecchio della conchiglia. Il custode addolorato di un’umanità che si sta perdendo: mi viene un’espressione di Vittorini, del genere umano perduto. Non parla, batte con il martello il legno dei tacchi. Ma osserva tutto, e tutto capisce. E prova pietà, e prova amore. C’è questa silenziosa complicità notturna, poi, con Nonno Benedetto, quando si siedono entrambi al banchetto. Loro sono i lavoratori, quelli che sostengono il peso. E lo fanno con una dignità muta.
Ma lo Zapatero assume anche, forse, almeno per me, questo supplemento di significato. È quasi un archetipo, un animale mitologico. Sì, potrebbe essere un Caronte, ma capovolto. Più che portare i morti dall’altro lato della riva, lui li aiuta a traghettare a ritroso. Anche se saltuariamente. Il suo compito è rimettere a posto le scarpe per i morti, perché possano tornare, di tanto in tanto, in sogno ai loro cari. La sua è un’ostinazione, una protesta. Verso la morte che ci toglie il respiro, e verso la morte “che si sconta vivendo”, potremmo dire, quella morte che lui ha sperimentato su sé stesso, esiliandosi dal consorzio umano, e di cui conosce ogni angolo. Ecco, forse più di tutti è proprio lo Zapatero a vegliare nel suo antro, e nel modo più lancinante, il desiderio del ritorno. È il guardiano della Nostalgia. E non può che essere lui, perché da qualche parte dentro di sé, in certe ore, quando osserva il movimento della città di fuori dalla sua cucina, sogna come nessun altro il ritorno a una vita che non ha vissuto. Lui abita una regione indefinita, tra la vita e la morte, ed esplora entrambe, e trattiene tutto, il dolore e la commozione. E tutto vorrebbe riparare, dalle storture dei piedi del mondo all’inevitabile distacco da chi abbiamo voluto bene. E questa necessità di riparazione lo porta a cercare anche per la Morte un altro modo, un’altra maniera. Quando scompare lui, non resta nessuno a fare da filtro, a mediare un passaggio. Il declino della sua famiglia, in fondo, e forse di tutta un’epoca, inizia inesorabilmente con la sua malattia e la sua scomparsa.
Le tue risposte sono sempre un’illuminazione. Con te si passeggia tra i libri e gli scrittori. È bello scoprire non solo lo Stassi scrittore, ma anche il Fabio lettore. Inscindibili o differenti? Quali dei due è nato prima? Il lettore amante di una certa narrativa che poi diventa scrittore, portando le letture in eredità al suo modo di scrivere, oppure lo scrittore che si ritrova a immaginare le proprie storie in una forma e da questa vocazione scritturale a leggere libri che la ricordino o che le siano simili?
 Non so, ho sempre letto. Ricordo i primi libri che ho avuto. Victor Hugo, Lermontov e Puskin con una copertina blu, che appartenevano a mio padre. Un’edizione del ciclo della Giungla di Emilio Salgari piene di illustrazioni e annotazioni e disegni e mappe che ancora conservo gelosamente. E il Meridiano di Ungaretti, Vita di un uomo, il primo Meridiano che uscì. Lo chiesi in regalo per un compleanno. Non ho mai dimenticato l’odore di quelle pagine, e la scoperta che feci attraverso di loro della letteratura. Scrivere un libro è, e resta, il mio desiderio più infantile e più grande.
Non so, ho sempre letto. Ricordo i primi libri che ho avuto. Victor Hugo, Lermontov e Puskin con una copertina blu, che appartenevano a mio padre. Un’edizione del ciclo della Giungla di Emilio Salgari piene di illustrazioni e annotazioni e disegni e mappe che ancora conservo gelosamente. E il Meridiano di Ungaretti, Vita di un uomo, il primo Meridiano che uscì. Lo chiesi in regalo per un compleanno. Non ho mai dimenticato l’odore di quelle pagine, e la scoperta che feci attraverso di loro della letteratura. Scrivere un libro è, e resta, il mio desiderio più infantile e più grande.
Mi incuriosisce molto questa tua attenzione e cura alla forma esterna della struttura narrativa. In Come un respiro interrottoventisei capitoli. Anche negli altri romanzi torna qualcosa di simile, o mi sbaglio? A quale necessità si presta?
 Sì, il Carnevale aveva 70 capitoli per richiamare la data in cui si concluse la Coppa Rimet, il 1970, l’ultimo mondiale romantico. Capablanca ne contava 64, quanti le case di una scacchiera. Charlot sei rulli e sette incontri con la Morte, come se per morire servisse rivivere per intero un’esistenza nel ciclo di una settimana. E quest’ultimo 26, appunto, come le lettere di un alfabeto.
Sì, il Carnevale aveva 70 capitoli per richiamare la data in cui si concluse la Coppa Rimet, il 1970, l’ultimo mondiale romantico. Capablanca ne contava 64, quanti le case di una scacchiera. Charlot sei rulli e sette incontri con la Morte, come se per morire servisse rivivere per intero un’esistenza nel ciclo di una settimana. E quest’ultimo 26, appunto, come le lettere di un alfabeto.
Per limitarsi solo ai numeri dei capitoli. Sono segnature di tempo, di spazio, di linguaggio, dettate forse dalla mia fiducia che la scelta di una misura possa conferire a una narrazione un senso matematico di necessità, se non proprio di bellezza, e che ogni manufatto umano si possa tradurre numericamente. Ma matematico per me è sinonimo di musicale. Uno spartito è la più perfetta delle strutture. Tempo, spazio e linguaggio, sempre. Forse per via della rudimentale formazione musicale che ho ricevuto, ho sempre cercato di pensare a un romanzo come a uno spartito. Ma tutte le impalcature, alla fine vanno smontate, e nascoste. Se c’è un senso, quello deve restare per suo conto, all’interno.
Sono sempre stato convinto che costruire un romanzo, o realizzare qualsiasi altra cosa, sia un po’ come tirare su un grattacielo. Ho sempre in mente gli scatti del fotografo che documentò la costruzione dell’Empire State Building. Piano dopo piano. Metro dopo metro. Ogni giorno entrava nel cantiere insieme agli operai. Saliva con loro sulle impalcature, camminava sulle travi, mangiava un sandwich sospeso sopra New York, e tutto per non perdere nemmeno un bullone spinto dentro al ferro, perché ogni bullone aveva per quel fotografo un significato, e c’era della bellezza nelle geometrie che disegnavano le assi di acciaio nel vuoto, e del coraggio negli uomini che ci lavoravano, come una famiglia di scimmie impazzite, con i berretti calcati sulla testa e le spalle nude e sudate.
Caro Fabio, non so se ti capita mai come lettore, un brivido lungo la schiena che sale toccando punti nascosti per fermarsi all’altezza del cuore e di lì come una scarica raggiungere il cervello. A me capita ogni volta che ti leggo, in ogni circostanza. Forse per questo Come un respiro interrotto mi è sembrato un titolo molto mio, perchè è proprio la mia condizione di lettura quando si tratta di te. Per me, forse, esiste la sindrome di Stassi come per altri la sindrome di Stendhal.
Un’ultima domanda, per poi lasciarti ai tuoi giri e ai tuoi viaggi: cos’è il respiro interrotto alluso dal titolo?
Allora, ultima domanda, dici.
Trovare il titolo giusto per questo romanzo non è stato facile. Ne ha avuti altri, durante la stesura. Si è chiamato Soledad. E poi con un verso di Caproni: Là dove non siamo mai stati. E poi con un verso di De André: In anticipo sul tuo stupore. Ma alla fine ho scelto quello che era più mio, e che riassumeva un po’ tutto. Come un respiro interrotto. È il modo che ha Sole di cantare. È l’utopia che abbiamo smarrito. È lu sciatu meu di Nonna Lupe, il fiato mio che si dice ai bambini, in Sicilia, e tra gli innamorati. È il respiro della malattia, che si incontra negli ospedali, e in questa storia ce ne sono tre, uno per suo fratello, uno per sua madre, uno per suo padre. È anche l’ultimo respiro. E in fondo è anche la struttura del libro, a respiri sospesi e a salti. Ogni capitolo, un respiro, più o meno lungo, più o meno trattenuto.
Fabio, se un anno fa avevi conquistato il podio tra tutti gli scrittori con cui avevo chiacchierato, oggi, vantando maggiore esperienza di scrittori e scritture grazie al sito che cresce e germoglia, non ti basta più. Il podio è quello del mio cuore, di lettrice appassionata ed emozionata.
Con L’ultimo ballo di Charlot il Chiacchierando (vanto e mi illudo che il sito porti fortuna a chi è nostro ospite!) ti ha condotto al Premio Campiello, non da vincitore ma davvero per poco e per circostanze a mio avviso non puramente letterarie. Con Come un respiro interrotto è una pagina ancora tutta da riempire!
Conservo, senza esserne mai stata testimone, questa immagine di te: un finestrino di un treno, la campagna romana che scorre e tu chino su un taccuino, che scrivi…
 Anche adesso ti sto scrivendo da qui, dal mio piccolo studio a forma di vagone, e tutto prende sempre il tempo del treno, anche la scrittura, è una specie di ragtime dei binari, in questo momento siamo arrivati alla stazione di Orte, forse anche i treni si muovono in levare. Ma mi piace risponderti dalla mia linea pendolare, che sono vent’anni e almeno venticinque giri del mondo in chilometri di strade ferrate…
Anche adesso ti sto scrivendo da qui, dal mio piccolo studio a forma di vagone, e tutto prende sempre il tempo del treno, anche la scrittura, è una specie di ragtime dei binari, in questo momento siamo arrivati alla stazione di Orte, forse anche i treni si muovono in levare. Ma mi piace risponderti dalla mia linea pendolare, che sono vent’anni e almeno venticinque giri del mondo in chilometri di strade ferrate…
