Sarebbe potuta andare così. Due comode poltrone in qualche angolo del Salone del Libro di Torino, gambe accavallate e una buona dose di emozione da parte mia nel rivolgere domande dirette a Ben Pastor. Ma quest’anno per me nessun viaggio a Torino, causa l’imminenza della nascita del terzogenito. Quindi anche in questo caso l’incontro con la scrittrice italostatunitense è stato solo virtuale. Un confronto speciale, ricco di dettagli e precisazioni, in cui Ben Pastor ha dimostrato una straordinaria generosità nel rispondere e nell’offrire il suo mondo letterario, nel descrivere il suo laboratorio di scrittura, nel provocare amabilmente noi lettori ad interrogarci sul senso e il valore della lettura. La cifra vera dimostrata dalla scrittrice è l’empatia che ha saputo creare sin dalla prima curiosità che le ho rivolto.

Se non erro Ben Pastor dovrebbe essere uno pseudonimo?
Il mio non è uno pseudonimo. Mi chiamo davvero Ben Pastor, dato che all’anagrafe statunitense – infatti sono anche cittadina USA – la mia identità legale risponde a Verbena (Ben è l’abbreviativo) Pastor (il cognome del mio primo marito). La mia nonna materna si chiamava Giuditta, che è anche il mio secondo nome!
Riservi tante sorprese per noi lettori italiani, e si può dire che hai già risposto alla mia prima curiosità. Sembra un nome d’arte e d’artificio e invece è il tuo nome vero, a cui si aggiunge anche la coincidenza onomastica. Io porto il nome della mia bisnonna materna! Ti confesso che all’inizio pensavo si trattasse di uno scrittore e solo leggendo la biografia e poi facendo delle ricerche ho scoperto che Ben Pastor è una splendida signora. È consapevole questo gioco che si crea tra maschile-femminile con il pubblico italiano o del tutto casuale e non voluto? Aggiungo anche un’altra curiosità legata alla tua doppia cittadinanza. I tuoi libri in Italia sono tradotti. Da dove nasce questa esigenza? Cosa significa per te leggerti in traduzione altrui e quali rapporti intrattieni con i traduttori? Non hai il desiderio di scrivere in italiano?

Per anni la mia vita professionale, nel mondo accademico americano, si è svolta all’insegna dell’inglese scritto e parlato. Questo ha ingenerato un’abitudine a pensare in inglese, con tutto ciò che la scelta comporta. Se si pensa in una data lingua, si costruisce una realtà secondo quella lingua: con buona pace della decostruzione, la mappa diventa il territorio; mappa e territorio coincidono. Ti voglio bene e Ti amo sono due gradazioni diverse nell’espressione di un sentimento. In inglese, il verbo love è usato più facilmente e in una varietà di circostanze: vale per la propria casa, per un vestito, per il proprio gatto, per la pizza, per la divinità. Certo, Ti voglio bene può essere tradotto con I care for you, un’espressione che tuttavia non ha la stessa valenza.
Tutto ciò per ribadire che scrivere in inglese per me non è tanto un’esigenza editoriale (anche se gli anglofoni sono più diffusi nel mondo di coloro che parlano italiano) quanto una scelta estetica e tecnica. Posso ottenere dalla prosa inglese sfumature che sarebbe quasi impossibile creare in italiano. Le lingue romanze sono eleganti, precise, ma non brillano per concisione. Le loro forme verbali sono complesse e a volte ridondanti. L’inglese è stringato ma ricchissimo, anche per gli apporti da altre lingue. L’abbondanza di sostantivi monosillabici e bisillabici permette di costruire frasi eloquenti ma leggere; la coesistenza di termini desunti dal latino e dall’anglosassone per esprimere lo stesso concetto permettono poi di calibrare l’“altezza” del linguaggio che si desidera usare. Lo stesso caldo benvenuto può assumere nuances diverse se è descritto come cordial o hearty, e ciò vale anche per gemelli diversi come amiable e lovely, famished e hungry, e via dicendo.
Naturalmente, scrivere in italiano non mi riesce difficile. Ci sono dei casi in cui, specialmente su commissione diretta (come nel caso di antologie italiane), ho scritto direttamente nella mia lingua d’origine. “Il giaciglio d’acciaio” in “Natale in giallo” (Sellerio 2011) ne è un esempio, ma anche “Turr alla Nica” in “Camicie rosse, storie nere” (Hobby & Work, 2010), e altri racconti.
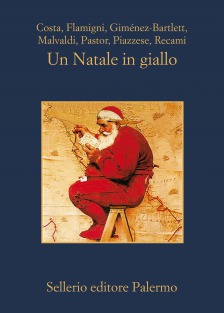
Detto questo, quello che mi interessa davvero affrontare, sia pure nell’ambito della detection, è la costruzione narrativa. Non a caso leggo volentieri la critica letteraria, privilegiando l’approccio strutturalista (Saussure, Levi-Strauss, Frye, Greimas), per il quale il mondo consiste di due livelli, visibile e invisibile: al primo fanno capo i fenomeni di superficie e l’esperienza concreta del quotidiano; al secondo le strutture che sottintendono e rendono comprensibile la realtà. Il mondo è un testo che aspetta di essere letto e interpretato, come osservano anche i semiologi. Dunque importano le strutture linguistiche, i generi, i personaggi, ordine, trama, prospettiva… Il romanzo principe da studiare dal punto di vista strutturalista è “Il grande Gatsby” di Scott Fitzgerald – che fra l’altro sta tornando in auge grazie al nuovo film con Di Caprio.

Pur ritenendomi piuttosto femminile, da sempre mi sono giudicata intellettualmente androgina. Di più, il mondo degli uomini – segnatamente quello dei soldati – mi ha attratto fino dall’infanzia. Un’infanzia del secondo dopoguerra, presso genitori e in luoghi che il conflitto aveva segnato profondamente.

In realtà, mi piace pensare che il mio gusto per raccontare le esperienze maschili sia più originario e profondo. Credo di mantenere un buon rapporto con quello che Carl Gustav Jung, uno dei miei maestri di pensiero, definisce animus, l’immagine psichica dell’uomo in una donna. Mi gratifica sentire da parte di uomini che scrivendo ho colto alcuni elementi del loro modo di essere e di sentire: è ciò che desidero fare. Avendo insegnato per anni, anche come direttrice del Master’s Program, nel più antico college militare privato degli USA, ho avuto modo di confrontarmi sia con l’universo dei soldati che con la sua alterità nei confronti dei civili e delle donne (anche se Norwich University da quasi trent’anni ha ottimi cadetti di sesso femminile). Ho alle spalle un matrimonio trentennale con un ufficiale di aviazione statunitense, ho vissuto presso basi aeree e da molto tempo frequento la letteratura e il collezionismo di militaria. Capisco Kipling quando si immaginava come legionario romano di guardia al Vallo di Adriano…
Trovo piuttosto riduttivo parlare di letteratura al femminile – anche perché non si parla mai di letteratura al maschile. Per quel che mi riguarda, anche se le donne sono comprimarie piuttosto che protagoniste nei miei romanzi, mi ingegno di costruire figure femminili credibili per l’epoca e le circostanze, ma anche singolarmente forti. Per esempio, i protagonisti delle mie tre serie (Martin Bora, Elio Sparziano, Karel Heida) hanno ottime relazioni con le rispettive madri, che in ogni caso mantengono un singolare ascendente sui maschi della famiglia. E tutti e tre si innamorano più perdutamente di quanto non vengano ricambiati: Odisseo è prigioniero di Circe e di Calipso, non viceversa!
Ti ringrazio, Ben, della tua disponibilità. La tua narrativa mi incuriosisce e affascina molto, come anche la tua personalità così particolare nel panorama italiano.
Sempre in tema di scrittura e processi creativi, forse potrà interessarti questa piccola ma curiosa iniziativa: http://passafoto.wordpress.com/le-librerie-di-scrittori-e-artisti
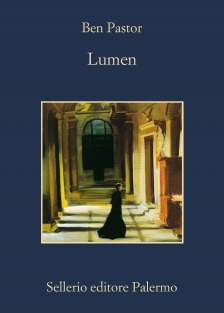
I tuoi libri legati al personaggio di Martin Bora sono considerati dei gialli, eppure mi sembra che nascondano altri interessi in cui la soluzione del mistero rimane relegata in secondo piano. In primo luogo la figura complessa di un militare nazista, l’umanità dolente e provata dalla guerra, la difficile situazione storica in cui le vicende sono ambientate, l’accurata e minuta ricostruzione storica. Qual è l’esigenza più profonda alla base della serie su Bora? Da dove nasce un personaggio così sfumato e ricco?
Mi ha sempre colpito come in molti film e serie televisive a carattere poliziesco, americane e non solo, chi investiga appaia totalmente assorbito dal caso in questione. Credo che sia importante considerare che nella vita di chi investiga, eventi quotidiani ed esistenziali si svolgono in contemporanea con il suo lavoro.

La giornata di un “investigatore per caso”, quale è Martin Bora, da ufficiale tedesco responsabile per i suoi soldati, e uomo di coscienza dalla psiche complessa, è invariabilmente lunga e stancante. La guerra e i suoi rischi, i dilemmi ideologici come quelli privati (legati al suo matrimonio),necessariamente richiedono attenzione. Risolvere singoli casi di omicidio nel contesto del grande crimine che è un conflitto mondiale deve sembrargli a tratti come un lusso.
A onta della sua professione, Bora è sensibile e colto, legato per via di relazioni familiari anche a chi adesso si trova sul fronte opposto al suo. Per lui, la vittima non è mai una curiosità scientifica da studiare con cinismo e humour a buon mercato. Visto il suo background internazionale di severo stampo mitteleuropeo, Bora partecipa dei privilegi e degli svantaggi della sua casta. Si trova a suo agio dovunque, ma si aspettano tutti molto da lui: famiglia, comandanti, maestri… E sebbene – come gli ricorda aspramente il patrigno generale – faccia parte della generazione di militari che hanno giurato fedeltà ad Adolf Hitler, non appartiene al partito nazista, tantomeno ne condivide il disegno criminale. Questo è il problema con il quale dalla Spagna del 1937 si deve confrontare, e con cui in qualche modo deve convivere, fosse pure per cercare di porre riparo al male che vede compiere.
Ma non dimentichiamo che, in termini di valutazione moderna, Bora è un ragazzo: volontario in Aragona a ventitré anni, ha già lo sfacelo di Stalingrado alle spalle a trenta, quando diventa colonnello. Perciò l’inquietudine sessuale, alcune insicurezze e ossessioni, l’occasionale sbandata fanno parte della sua realtà, come per ogni giovane.

Fin dall’inizio il mio desiderio, sviluppando il personaggio di Martin Bora anche in base alle biografie di alcuni dei membri della resistenza interna all’esercito tedesco, era quello di mostrare come uomini dal provato patriottismo, nella maggioranza conservatori illuminati, abbiano immaginato un’Europa diversa, e siano stati pronti a pagare i loro ideali con la vita. Ricordare quanti, avendo molto creduto e molto sofferto, dissentirono da una generazione che ha invece commesso enormi crimini senza rimorso, è il minimo che chi, come me, ha avuto la fortuna di nascere in un mondo libero possa fare. Se poi un membro di quel coraggioso manipolo (gli happy few di Enrico V) è anche un provetto investigatore, ben venga!
Se già subivo il fascino di Bora, dopo questo tuo straordinario ritratto ne sono ammaliata. Una caratteristica dei tuoi romanzi che ho riscontrato dalla parzialità del mio giudizio di lettrice è la lentezza. La tua scrittura ama soffermarsi sui particolari, sui paesaggi, sulle sfumature di atteggiamenti e comportamenti per il puro gusto di dare un quadro particolareggiato della situazione. Questo in parte stride con i ritmi incalzanti del genere noir o giallo, come noi lettori siamo abituati a leggere. Non ti nego che all’inizio ne sono stata spiazzata, poi invece ho compreso che era proprio lì, in questa lentezza ricca di mille suggestioni, che si annidava l’anima vera di Ben Pastor. Ti ritrovi in questa mia impressione di lettura o credi che sia fuorviante?
Intanto non posso che ringraziarti, Ben, per la profondità delle tue risposte e la precisione della tua attenzione!
Da quando Aristotele ha immaginato le Categorie, si è cercato di fare ricadere ogni esperienza umana sotto una specifica rubrica. Dalla tassonomia a ogni genere di lista, pensiamo quasi esclusivamente in termini di appartenenza a questo o a quel genere. È vero, i romanzi con Martin Bora sono tecnicamente dei gialli (contengono la risoluzione di uno o più crimini), ma sono anche classificabili come romanzi storici (si svolgono tra la guerra di Spagna e la fine del Secondo conflitto mondiale). Allo stesso tempo sono stati considerati romanzi psicologici, per l’interesse e l’attenzione al mondo interno dei personaggi. Che dire?
Per me un buon romanzo deve soprattutto saper raccontare una storia. È quello che mi ingegno a fare, sapendo che la storia di ognuno di noi non è mai semplice né scontata. Tantomeno può esserla quella di un giovane che vive in uno dei periodi più drammatici della storia recente, come soldato, come tedesco, come uomo di coscienza. Sarebbe fin troppo facile renderlo un investigatore seriale sempre uguale a se stesso, che di volta in volta si confronta brillantemente con un diabolico caso da risolvere. Per Bora gli intoppi sono quotidiani. La guerra fa irruzione in tutto ciò che fa e pensa, anche nella sua investigazione, che spesso gli viene ordinata ma altre volta “capita”, grazie al suo profondo senso della giustizia. L’esigenza della serie, se così si può dire, è nella rivendicazione della decenza umana che può sopravvivere nelle circostanze peggiori (devo crederci). In questo sono in ottima compagnia: “Il gladiatore” di Ridley Scott e il James Bond di “Skyfall” sono solo due esempi cinematografici recenti del personaggio duro ma intimamente onesto che si muove in un mondo spietato.
Quanto alle sfumature del carattere di Bora, sono necessarie quando le tinte di base sono così forti. L’uniforme che Martin indossa, la nazione cui è fedele, la casta privilegiata cui appartiene, rischiano ogni volta di renderlo inaccettabile: solo l’etica personale e la sua pietas possono illuminarne l’oscurità. E le luci sono tanto più chiare quanto più difficile è farle apparire nella sua difficile giovinezza.

Quanto ai ritmi interni della mia narrazione, parto dal presupposto che anche i paesaggi, i climi, le “distanze” fisiche e psicologiche tra i personaggi devono essere adeguatamente valorizzati. È una questione di “respiro”: dato che tendo, nel contempo, all’epica e all’analisi psicologica (che non sono affatto in contraddizione tra loro), mi prendo tutto lo spazio e il tempo che reputo necessari. Penso che il piacere del testo (qui parlo anche da lettrice) nasca pure da questo: un intero mondo a poco a poco compare davanti ai tuoi occhi, con calma, senza fretta ma pure senza pause morte. Uno straordinario affresco come “Moby Dick” (romanzo che mi ha influenzata moltissimo) non poteva essere contenuto in 200 pagine; ogni storia ha la sua lunghezza, il suo intimo modo di dispiegarsi. Certo, l’importante è non indulgere in lungaggini inutili o barocchismi estetizzanti, ma, detto questo, è altrettanto importante non essere grossolani, o narrativamente super-eccitati laddove non serve. Che cosa è meglio: ingollare in un sorso solo un buon bicchiere di vino o centellinarlo con tutta l’attenzione che si merita? Al riguardo, non ho dubbi.
Cara Ben! la similitudine del calice di vino si adatta benissimo ai tuoi romanzi, che non solo vanno libati con la giusta calma e concentrazione, ma anche amati, come un vino pregiato, assaporandone tutti gli elementi e i molteplici accessori: dal colore, al bouquet, al primo assaggio e solo alla fine procedere a sorsi, che siano sempre forieri delle infinite suggestioni che sanno offrire.
Veniamo alla conclusione. Un’ultima domanda, che vale anche come saluto. Sei reduce dal Salone del libro di Torino. Che effetto ti fa tornare in Italia e incontrare i lettori italiani? quale percezione ti rimane, tornata in America, dell’accoglienza che ti riservano?
Mi chiedi dei miei incontri con i lettori. Bene, sono di due tipi, sia in Italia che in altri Paesi: incontri diretti in occasione di presentazioni e festival; incontri “mediati” dalla posta elettronica del mio sito bilingue, www.benpastor.com (non ho un account facebook o un blog, soprattutto perché non avrei tempo per curarli). In generale, la mia impressione è ottima; ho quasi sempre a che fare con persone molto sensibili, intelligenti e colte. In proposito, mi onoro di avere tra i miei fan in America uno dei massimi studiosi di filosofia del diritto, un luminare universitario di linguistica e il “principe” degli avvocati di Manhattan: quest’ultimo ha anche ispirato Tom Wolfe per uno dei personaggi di “The Bonfire of Vanities” (credo che in Italia sia arrivato come “Il falò delle vanità”).
Una cosa che ogni tanto mi sorprende (in positivo) è constatare come non pochi lettori – e lettrici – abbiano istituito un vero rapporto “affettivo” (non saprei come altro definirlo) con Martin Bora: mi chiedono di lui; come sta, quali sorprese riserverà in futuro la sua vita sentimentale; dove l’Abwher lo invierà nel prossimo romanzo, e, soprattutto, che fine farà nell’aprile del 1945 (a quest’ultima domanda, tuttavia, non risponderò neppure sotto tortura, pur avendo già scritto nel mio cervello l’ultima pagina di quello che, nei miei progetti, sarà il romanzo conclusivo della serie).
Confesso che mi fa un grandissimo piacere osservare come per molti lettori Martin Bora sia diventato un vero e proprio amico; e tale circostanza, naturalmente, mi responsabilizza molto. Quando un personaggio si trasforma in un medium, quasi a dispetto delle intenzioni iniziali dell’autrice, allora si crea una dimensione inedita nel rapporto tra scrittore-romanzo-fruitore, di cui bisogna tenere conto. Qui il discorso rischia di farsi molto lungo, ma per non tediare mi limiterò a una sola considerazione: se Martin Bora può in qualche modo influenzare i lettori, bene, il mio sforzo – morale oltre che letterario – è che questa influenza sia sempre verso valori “alti” e condivisi, quali giustizia, onestà, rettitudine, spirito di sacrificio, altruismo etc. Certo, Bora è un personaggio complesso e per qualche verso sanamente contraddittorio (del resto è figlio di tempi terribili), ma il mio desiderio è che alla fine in lui emerga sempre una tensione morale che lo spinga a compiere le scelte giuste – per quanto non di rado dolorose o apparentemente discutibili – per se stesso e, soprattutto, per gli altri. Qualcuno ha definito Martin Bora l’uomo giusto – in senso ebraico – nella divisa sbagliata. Ma non è forse questo, tranne qualche fortunata eccezione, il destino esistenziale di tutti noi? Sta proprio qui, ritengo, il fascino più riposto e “seduttivo” del personaggio, e da tale impostazione non intendo deflettere, almeno fin quando avrò qualcosa da dire, e da fargli dire.
La nostra non è stata una chiacchierata, ma qualcosa di molto incisivo, grazie alla generosità delle tue risposte. Un confronto sempre puntuale, ma molto ricco e dettagliato, di cui ti sono molto riconoscente e grata.
Cara Giuditta, sono io che ringrazio te per le domande e lo spazio che gentilmente hai voluto concedermi! Grazie mille di tutto & keep in touch!
Booktrailer dell’ultimo romanzo Il cielo di stagno
